Pane di Altomonte
Il pane, alimento semplice e universale, ha rappresentato per secoli non solo una necessità quotidiana, ma anche un simbolo di condivisione, ospitalità e identità culturale. In molti borghi italiani, la tradizione della panificazione è rimasta viva, tramandata di generazione in generazione e oggi riconosciuta come patrimonio immateriale da preservare. Dai forni comunitari agli antichi mulini, ogni territorio custodisce un segreto, un profumo e un sapore che raccontano la storia di chi lo abita.
In questo viaggio andremo a scoprire sei borghi italiani, ognuno legato a un pane unico e identitario: Altomonte in Calabria, Triora in Liguria, Monte Sant’Angelo in Puglia, Altopascio in Toscana e Chioggia in Veneto.
Calabria: Il Pane di Altomonte
Altomonte, borgo medievale incastonato tra i monti del Pollino e la piana di Sibari, è famoso per il suo pane rustico e profumato. Il Pane di Altomonte nasce dalla fusione di grani locali, acqua di sorgente e lievito madre, lavorati secondo rituali antichi che resistono al tempo. La crosta dorata e croccante custodisce una mollica morbida e compatta, capace di mantenersi fragrante per più giorni.
La tradizione altomontese lega la panificazione ai momenti comunitari: i forni a legna, ancora presenti in alcune contrade, erano un tempo il cuore pulsante del borgo, dove le famiglie portavano a cuocere le proprie forme, trasformando l’attesa in occasione di incontro. Il momento ideale per scoprire Altomonte è durante la Gran Festa del Pane, quando le vie del borgo si trasformano in un grande forno a cielo aperto, celebrando l’arte antica della panificazione.

Liguria: Il Pane di Triora
Il Pane di Triora è uno dei prodotti tipici più affascinanti della Liguria, legato indissolubilmente al borgo medievale di Triora, nell’alta Valle Argentina, famoso per i processi alle streghe (bàggiure) del XVI secolo. Proprio questa tradizione popolare intreccia la storia del pane: si racconta infatti che un tempo venisse impastato anche con segale cornuta, un cereale infettato dal fungo Claviceps purpurea, noto per gli effetti psicotropi sugli esseri umani. Secondo la leggenda, questo ingrediente avrebbe contribuito alle visioni e ai comportamenti ritenuti “stregoneria” dalle autorità dell’epoca. Ciò che rende il Pane di Triora davvero particolare è la sua cottura su tavole di legno cosparse di crusca. Questa tecnica, nata inizialmente per evitare che l’impasto si attaccasse, si rivelò col tempo un valore aggiunto: la crosta risultava più spessa e saporita, mentre l’interno rimaneva morbido e compatto. In alcuni casi, per arricchire ulteriormente il profumo, si cuoceva addirittura su foglie di castagno adagiate sulla crusca.
Grazie alla sua lunga conservazione e al suo sapore rustico e leggermente acidulo, questo pane è perfetto per accompagnare minestre e piatti tipici liguri, ma dà il meglio di sé con i formaggi locali, in particolare con il brussu, un formaggio fresco fermentato con grappa o brandy, che crea un contrasto intenso e indimenticabile.
Il pane di Triora ha ottenuto il riconoscimento di Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT) e rappresenta un esempio virtuoso di come un piccolo borgo possa trasformare la propria tradizione in elemento di identità e promozione turistica.

Puglia: Il Pane di Monte Sant’Angelo
Il Pane di Monte Sant’Angelo, recentemente riconosciuto come Presidio Slow Food, è molto più di un semplice alimento: è il simbolo identitario di una comunità che da secoli tramanda i saperi della panificazione tradizionale. In questo borgo del Gargano, famoso per il Santuario di San Michele Arcangelo patrimonio UNESCO, il pane nasce da un rito antico che inizia nel cuore della notte, quando i fornai rigenerano il lievito madre e impastano le farine di grani teneri locali, insoliti in una Puglia dominata dal grano duro. Le forme sono imponenti – pagnotte rotonde che possono arrivare a 80-90 cm di diametro e pesare anche oltre 10 chili – con crosta croccante color mandorla e una mollica soffice e compatta, capace di conservare fragranza fino a due settimane. La cottura avviene nei tradizionali forni di pietra refrattaria, accesi quasi senza sosta, che donano al pane il suo aroma inconfondibile. Non è solo un prodotto da forno, ma la base della cucina locale: protagonista di piatti poveri e gustosi come il pancotto e l’acquasale, compagno perfetto di pomodoro fresco e olio extravergine Dauno DOP. Il pane di Monte Sant’Angelo racconta la memoria della civiltà contadina e custodisce un valore sacrale: ogni pagnotta non è soltanto nutrimento, ma testimonianza viva di un patrimonio culturale che unisce la comunità e accoglie chiunque vi giunga sulla montagna sacra del Gargano.

Toscana: Il Pane di Altopascio
Il Pane di Altopascio è uno dei simboli più autentici della tradizione toscana, tanto da valere al borgo in provincia di Lucca l’appellativo di “città del pane”. Le sue origini risalgono al Medioevo, quando i Cavalieri del Tau, confraternita ospitaliera che accoglieva i pellegrini lungo la Via Francigena, ne facevano dono ai viandanti come gesto di sostegno e ospitalità. Ancora oggi questo legame con il passato si respira nelle strade del borgo, dove il pane rimane emblema di comunità e solidarietà. La sua particolarità sta nella lavorazione: è infatti un pane sciocco, privo di sale, preparato con farina e acqua e fatto lievitare grazie a un impasto tradizionale chiamato sconcia, rinnovato ogni giorno. Ha forma quadrangolare (la tipica bozza) o allungata (il filone), una crosta sottile e dorata e una mollica morbida e compatta, perfetta da gustare con salumi toscani, formaggi stagionati o come bruschetta con olio extravergine delle colline lucchesi. Non è solo un alimento, ma un vero e proprio pilastro culturale, celebrato ogni anno durante la Festa del Pane, che anima Altopascio con degustazioni, rievocazioni storiche e momenti di convivialità, rinnovando così una tradizione secolare che continua a raccontare la storia di un territorio e della sua gente.

Veneto: Il Pane di Chioggia
Il Pane di Chioggia, noto come bossolà o bussolà, è uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione lagunare veneta e affonda le sue origini almeno al Seicento, come attestano antichi documenti conservati negli archivi locali. Considerato il pane dei pescatori, il bossolà era apprezzato per la sua lunga conservazione e per la resistenza al clima umido e salmastro della laguna: secco, croccante e privo di muffe, poteva infatti accompagnare i marinai e i chioggiotti nelle lunghe battute di pesca in mare aperto. La sua caratteristica forma ad anello deriva da un’usanza pratica: veniva infilato sugli scalmi delle barche per essiccare al sole e conservarsi più a lungo. L’impasto è semplice, a base di farina, acqua, lievito e sale, lavorato a mano e poi arrotolato fino a ottenere il tipico cerchio che, una volta cotto, assume una consistenza fragrante e friabile. Oggi il bossolà viene preparato nei panifici artigianali della città seguendo la ricetta tramandata di padre in figlio, ma può presentare anche piccole varianti con sesamo o senza lievito, pensate per le esigenze moderne. Versatile e genuino, si gusta sia con il dolce – marmellate, miele, cioccolata – sia con il salato, abbinato a salumi, formaggi e naturalmente al pesce della laguna, continuando così a raccontare la storia di Chioggia e del suo legame indissolubile con il mare.

Ph. Chioggia estate
Il viaggio nei Borghi del Pane ci porta a scoprire non solo prodotti unici e antiche ricette, ma soprattutto l’anima di comunità che da secoli trovano nel pane un simbolo di identità e condivisione. Dal profumo rustico del Pane di Altomonte alla leggenda che avvolge quello di Triora, dalle grandi forme garganiche di Monte Sant’Angelo al pane sciocco di Altopascio fino al bossolà dei pescatori di Chioggia, ogni borgo racconta una storia fatta di tradizioni, gesti tramandati, e valori che resistono al tempo. In questi luoghi, il pane non è soltanto alimento: è memoria, cultura, rito quotidiano e occasione di incontro. Visitare i borghi del pane significa allora riscoprire il gusto autentico dell’Italia, fatto di semplicità, autenticità e radici profonde che continuano a nutrire il presente.
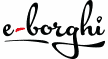

0 Commenti