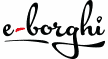Nominata Capitale della Cultura 2022, la splendida isola di Procida è un’autentica perla di rara bellezza immersa tra i cristallini blu cobalto del Golfo di Napoli. Costituita da nove storiche contrade, Procida è la meta perfetta per gli amanti delle esperienze autentiche
Immagini del borgo
Incuneata tra i cristallini blu cobalto del Golfo di Napoli, sorge la splendida isola di Procida, Capitale della Cultura 2022, un’autentica perla di rara bellezza della regione Campania. L’affascinante territorio di Procida si compone dell’omonima isola e del suo isolotto vicino, Vivara, due gemme settecentesche nell’incantevole scenario delle isole Flegree.
Meta perfetta per gli amanti delle esperienze autentiche, la pittoresca Procida vanta una straordinaria varietà di angoli e scorci da scoprire. Ricoperta dal verde delle sue colline, la più alta delle quali è Terra Murata (91 m), l’isola si fa ammirare per la bellezza del suo borgo fortificato di origini medievali che domina dall’alto.
Il litorale di Procida, delineato da un mix perfetto di spiagge sabbiose e coste a picco sul mare, offre una serie di baie e promontori che si rivelano veri angoli di paradiso per la nautica da diporto. Su queste onde si affacciano tre porticcioli posti sui versanti settentrionale, orientale e meridionale dell’isola, mentre una parte del litorale è prudentemente preservata dall’area marina protetta Regno di Nettuno.
L’autentica essenza di Procida si coglie nelle sue nove storiche contrade, chiamate grancìe, ognuna con il proprio carattere e personalità: dal borgo più antico, Terra Murata, al caratteristico borgo di pescatori, Corricella, passando per il vivace centro abitato di Sent’cò che ospita il porto commerciale di Marina Grande, fino alla favolosa Chiaiolella e al suo porto turistico nella parte meridionale dell’isola.
Nel cuore dell’isola di Procida si trova la zona di Sant’Antonio, il cui epicentro è Piazza Olmo, punto di partenza ideale per esplorare la sua rete di vicoli che si diramano in ogni direzione. Da qui, infatti, è possibile raggiungere a piedi ogni angolo dell’isola: niente dista più di 1,5 km!
La Chiaiolella, situata esattamente all’estremità opposta al porto, è nota per la sua Spiaggia del Ciracciello, delimitata da due magnifici faraglioni tufacei, risultato della frana del costone roccioso che separava i due litorali e divenuta la spiaggia più lunga dell’isola. Grazie alla sua estensione, la zona offre sia ampie spiagge libere che attrezzature turistiche, rendendola l’ideale per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento.
Infine, non dimenticate la magica spiaggia del Pozzo Vecchio, raggiungibile imboccando via Cavour alle spalle della Chiesa di S. Antonio Abate. Questa iconica spiaggia, nota per essere stata immortalata nel film “Il Postino”, offre un paesaggio mozzafiato e un’atmosfera da sogno che vi farà innamorare di Procida all’istante.
Se state cercando un rifugio da sogno in cui immergervi nella bellezza della cultura e della natura italiane, Procida è la destinazione da sogno che fa per voi. Con le sue incantevoli coste, i suoi suggestivi borghi e la sua affascinante storia, questa isola vi accoglierà a braccia aperte.
Borgo di Procida
Comune di Procida
Provincia di Napoli
Regione Campania
Abitanti: 10.496 procidani
Altitudine centro: 27 m s.l.m.
il Comune fa parte di:
Città del pesce di mare
Aree naturali protette:
Area naturale marina protetta Regno di Nettuno
Riserva naturale statale Isola di Vivara
Il Comune
Via Libertà 12 – Tel. 081-8109203
IN AUTO
- Da Napoli: Proseguire il Prolungamento Pasquale Borelli, girare a destra per la SP193 e proseguire per la SP1. Continuare sulla A1/E45, seguire la direzione per Napoli e prendere l’uscita per il porto. Attraversare Napoli, arrivare al Molo Beverello e proseguire tramite collegamento via mare. Attraversare Ischia, Casamicciola Terme e Lacco Ameno, continuare sulla SPEXSS270 ed entrare in Forio.
- Da Pozzuoli: Girare a destra per la Via Comunale Tavernola e imboccare l’A56 in direzione Tangenziale. Prendere l’uscita in direzione Pozzuoli, girare a destra per la SP47 e attraversare Pozzuoli. Girare a destra per Largo San Paolo e prendere il collegamento via mare.
IN TRENO
- Stazione ferroviaria di Napoli
IN AUTOBUS
- Stazione di Piazza Garibaldi di Napoli
IN AEREO
- Aeroporto di Napoli
VIA MARE
- Molo Beverello di Napoli
- Porto di Pozzuoli
Nella cucina procidana fanno da padrone i prodotti della terra (in particolare carciofi e limoni) e del mare. Il limone procidano ha la particolarità di essere molto grande, poco acre e con l’albedo (la parte bianca compresa tra la buccia e la polpa) molto sviluppata. Uno dei piatti più particolari in cui viene utilizzato questo prodotto è la tradizionale insalata di limoni, fatta con limoni di Procida a tocchetti, aglio, olio, peperoncino, sale e menta. Ottima anche la produzione del classico limoncello. Molto particolare anche la pasta detta pescatora povera, nella quale si utilizzano peperoncini verdi fritti ed alici. Tra i dolci della tradizione troviamo il casatiello dolce, una sorta di ciambella tipicamente pasquale lievitata con il lievito madre solitamente utilizzato per il pane. Più moderna invece è la lingua, un dolce composto da pasta sfoglia ripiena di crema pasticciera e ricoperto di zucchero.
- Mercato settimanale: ogni venerdì, in centro;