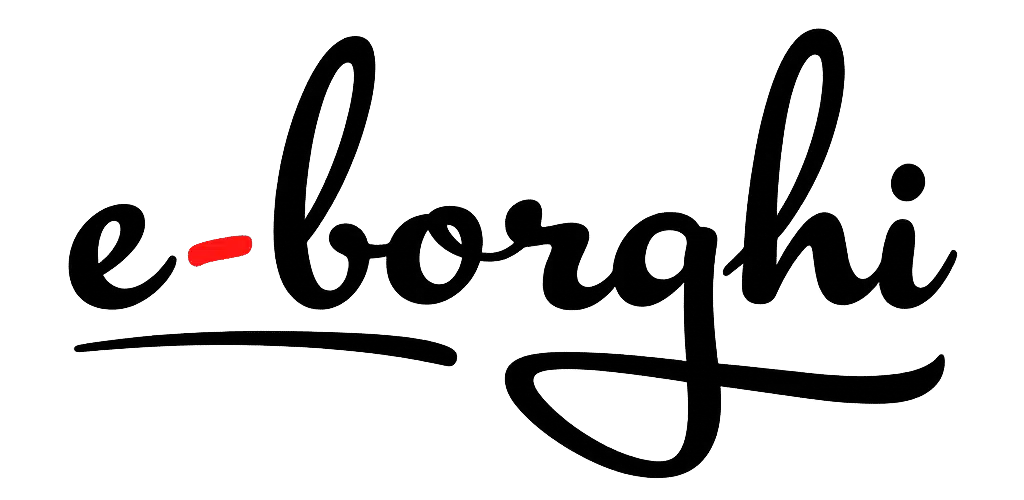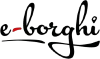È l’edificio più antico di Castelseprio, l’unico sopravvissuto alla distruzione e l’abbandono dell’antico borgo fortificato, grazie alla devozione legata al luogo di culto. Il motivo di interesse principale è comunque l’originalissimo e straordinariamente conservato ciclo di affreschi che decora il vano dell’abside, tra le testimonianze più importanti della pittura muraria europea nell’Alto Medioevo.
Appartiene dunque all’età carolingia per epoca di costruzione, ma a quella longobarda per concezione ideale e per continuità architettonica, che rimanda indietro fino alle basiliche paleocristiane di Milano del IV-V secolo e che sarebbe proseguita fino all’XI secolo.
La chiesa si presenta esternamente con una rustica semplicità, preceduta da un atrio con un grande arco, aperto nel XVII secolo, mentre in pianta presenta un’unica navata rettangolare, non molto lunga, con un’abside per ciascun lato oltre quello d’ingresso. Le tre absidi sono tra loro uguali tranne che per la disposizione delle finestre. All’esterno, esse sono rinforzate da contrafforti e coperte da bassi spioventi semiconici.
Internamente la chiesa doveva essere intonacata e coperta da affreschi e stucchi, mentre il pavimento presentava motivi a intarsio in marmo. Dalla chiesa probabilmente proviene anche l’Epitaffio di Wideramn, rara testimonianza della cultura funeraria longobarda scritta.
Gli affreschi antichi rimasti si dispiegano sulle pareti dell’abside centrale, compreso il lato che dà verso la chiesa, separato dalla navata da una parete dove si apre un arco a tutto sesto. Gli affreschi, rinvenuti casualmente nel 1944, rappresentano scene dell’infanzia di Cristo ispirate, sembra, soprattutto ai Vangeli apocrifi. Sorprendente è la tecnica compositiva, che lascia emergere una sorta di schema prospettico di diretta ascendenza classica, oltre a un chiaro realismo nella rappresentazione di ambienti, figure umane e animali. Il ciclo di affreschi testimonia così la permanenza, in tarda età longobarda, di elementi artistici classici sopravvissuti all’innesto della concezione germanica dell’arte, priva di attenzione ai risvolti prospettici e naturalistici, e più concentrata sul significato simbolico delle rappresentazioni.